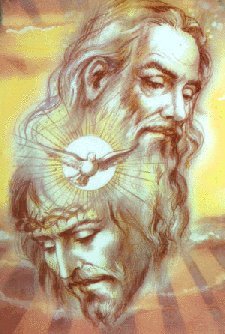Da La Libertà di Reggio Emilia del 1° luglio 2017
1) Le beate Giovanna da Reggio e Arcangela da Trino Vercellese e Santa Caterina da Bologna
La seconda metà del ‘400 vede apparire rispettivamente a Reggio e a Mantova due straordinarie figure di suore carmelitane: a Reggio la Beata Giovanna Scopelli (1428-1491) e prima a Parma e poi dal 1492 a Mantova la Beata Arcangela Girlani da Trino Vercellese (1460-1494). Entrambe dotate di carismi straordinari e complementari. La beata Giovanna nel suo amore per Cristo crocifisso anelava a condividerne i patimenti per ottenere grazie di ogni genere per il popolo. La beata Arcangela invece aveva uno speciale amore per la SS. Trinità.
Entrambe hanno fondato un nuovo monastero. La beata Giovanna il Monastero di Santa Maria del Popolo, la beata Arcangela il Monastero di Santa Maria del Paradiso detto anche il Carmelino di Mantova. La prima riviveva i patimenti di Gesù e subiva gli attacchi del demonio. La seconda mostrava la perfezione della vita devota, resa possibile dalla resurrezione di Gesù. La sua vita era immersa nell’amore della SS. Trinità in un modo che faceva pensare al Paradiso. Il desiderio della Beata Arcangela, priora del nuovo monastero, era quello di mostrare al mondo la perfezione della vita angelica. Voleva che le sue monache pur vivendo in terra fossero come assorte in Cielo. Cadeva spesso in estasi e lievitava dal suolo.
Due beate dell’ordine carmelitano ed entrambe dipendenti dal Convento di Mantova, sotto il quale erano sia Parma che Reggio. La complementarietà della loro azione era un invito ad adorare e a condividere tutta la vita di Gesù.
Esse hanno avuto il privilegio di non vedere la corruzione del proprio corpo ed entrambe sono state sfrattate dal convento carmelitano, in cui erano venerate, per le soppressioni napoleoniche, per approdare, la beata Giovanna nel 1798 nel Duomo di Reggio, la Beata Arcangela nel 1802 nella chiesa dell’ospedale di S. Lorenzo a Trino Vercellese. Dal 1803 la Beata Giovanna si trova nella Cappella Rangoni sotto l’immagine della Madonna del Pilastro coeva alla Scopelli e davanti alla quale, mentre assisteva alla messa, fu ucciso il governatore di Reggio Giovanni Gozzadini nel 1517.
Il convento e la chiesa del convento delle Monache Bianche, dove si è conservato il corpo della Beata fino al 1798, sono stati demoliti all’inizio dell’800 e sul terreno è stata prima costruita una casa Bolognini e poi dal nobile Roberto Levi, fratello di Ulderico, la propria villa in stile liberty passata poi ai Terrachini fino a cinque anni fa allorchè è diventata proprietà della Iter.spa. Ma l’orto e la via adiacente, detta delle Bianche, sono state acquistate nel 1873-75 da Don Zefirino Jodi che vi ha eretto il muro di confine a levante del Pio Istituto Artigianelli.
Contemporanea delle due beate è la clarissa Santa Caterina Vigri Bolognese (1413-1463) Il padre, ferrarese, proveniva dalla corte estense. E’ stata priora del nuovo convento del Corpus Domini aperto a Bologna. Il suo corpo incorrotto e flessibile si venera nella cappella appositamente costruita per lei nel convento stesso. Essa conosceva i segreti altrui e preannunciava eventi futuri. Ha scritto il Trattato delle sette armi spirituali, dove l’umiltà era inseparabile dall’obbedienza. Il suo monastero era aperto a tutti, che non solo ricevevano lumi per la loro vita interiore ma anche ammiravano il nobile comportamento della santa, nonostante le sue grandi sofferenze. Il suo ruolo era quello di donarsi come ostia consacrata e alimento spirituale a coloro che incontrava.
2) Le beate Domenica Lazzeri e Maria de Morl
Nella metà dell’800 si ripresenterà in Trentino Alto Adige una coppia di Beate simile a quella di Reggio e Mantova. E’ bene ricordarle per precisare meglio il rapporto tra le Beate Arcangela e Giovanna. A Caprara, paese trentino aggrappato ad un monte, vive la Beata Meneghina o Domenica Lazzeri (1815-1848), poi sepolta nel cimitero dietro alla Chiesa parrocchiale, e nell’ Alto Adige di lingua tedesca, ma che parlava anche l’italiano, Maria de Morl (1812-1868), di cui è in corso il processo di beatificazione, detta l’estatica di Caldaro, dell’ordine secolare delle Terziarie francescane, sepolta nell’anticamera del Cimitero di Caldaro. Entrambe stigmatizzate, tutti i giovedì e venerdì rivivevano la passione di Cristo e versavano il sangue dalle stigmate delle mani, dei piedi, del capo e del costato. Rimanevano immobili a letto senza mangiare né bere. La prima teneva sempre le finestre aperte per mostrare il calore dell’amore di Gesù quando era in croce. Per una settimana rimase con l’Ostia consacrata sulla lingua. La seconda era spesso in estasi e in estasi ogni settimana riviveva la passione di Gesù. Abitava nel ridente paese di Caldaro allietato da un delizioso laghetto di montagna. Pur di lingua tedesca amava e conosceva l’italiano. Tra Capriana e Caldaro, separate dalla lingua, c’era la stessa differenza che tra Reggio e Mantova nel ‘400. Allora Reggio era un’umile città di provincia, mentre Mantova, città ducale, viveva in pieno lo splendore del Rinascimento col Mantegna
3) Il Correggio e l’ Ariosto
Le beate Giovanna e Arcangela vivevano la passione e la resurrezione di Gesù in monasteri, che dovevano essere aperti alle città per svelare a tutti le meraviglie dell’Amore Divino. Mediavano tra Dio e gli uomini davanti a tutti perché si vedesse bene quando Dio aveva fatto e continuava a fare per gli uomini. Coi digiuni e le dure penitenze le due beate ottenevano grandi miracoli sia per lo spirito che per il corpo. La beata Giovanna subiva le persecuzioni del demonio perché con la sua impressionante capacità di pregare otteneva grandi conversioni. Il razionalismo di Leonardo da Vinci (1452-1519) e di Machiavelli (1469-1527), proveniente dai colli fiorentini, trovava nella pianura padana l’argine che gli impediva di dilagare in Europa.
Il Correggio (1489-1534) e l’Ariosto (1474-1533), contemporanei della Scopelli, restituivano a Dio il primato sull’uomo. Il Correggio concentrando tutta la luce, che sprigionava dai giganti di Leonardo, nella Figura di Gesù Bambino, quasi a voler rifondare la Chiesa del Rinascimento in risposta alle critiche di Lutero, che nel 1517 cominciava la sua dura contestazione alla chiesa di Roma. L’Ariosto facendo del Cavalier Orlando un pazzo scatenato incapace di comprendere il cambiamento dei tempi che allora era guidato dalle donne tra cui Angelica, che sposerà un umile soldato e per di più musulmano.
L’Ariosto e il Correggio vedono nella grazia femminile quell’elemento fino ad allora assente nel Rinascimento, che poteva salvarlo dando un’impronta trinitaria al naturalismo di Raffaello, che si sforzava di fare scendere in terra i giganti fiorentini ma asessuati di Leonardo e Michelangelo.
I due reggiani hanno scoperto il segreto della dolcezza femminile, che è l’apertura alla vita. Il Correggio ha restituito alla Vergine Maria quell’umile femminilità che era necessaria al Bambino Gesù per ritornare sulla terra. L’Ariosto darà alla donna la parità con l’uomo, pur riconoscendone le straordinarie differenze. Ma tutto questo sarebbe stato possibile senza la Scopelli, che aveva fatto della grazia femminile il mezzo per convertire e disarmare i peccatori?
La singolarità di Reggio sta nel fatto che sono stati gli uomini a capire l’importanza della grazia femminile, senza la quale avevano perso la propria identità. L’uomo di Leonardo, né uomo né donna, era diventato un automa com’era la Gioconda che sorride a chi la guarda prima negli occhi come ad un comando. Anche oggi la riscoperta della grazia femminile può rinnovare il mondo.
4) Santa Teresa d’Avila e Madre Maria Francesca dello Spirito Santo.
Dopo che l’opera delle due beate Giovanna ed Arcangela aveva prodotto il rinnovamento del Rinascimento coll’Ariosto e il Correggio, i fatti straordinari che avevano accompagnato le due beate continuavano nella vita di Santa Teresa d’Avila (1515-1582). Essa riuniva l’aspetto della Passione con quello della Resurrezione di Gesù in un’unica persona e in un unico monastero, chiudendo il momento eroico dell’inizio del nuovo corso carmelitano con la riforma dei Carmelitani Scalzi. La clausura doveva favorire la preghiera. Il corpo della santa è incorrotto e si venera nella Chiesa dell’Annunciazione di Alba de Tormes.
Eleonora d’Este (1643-1722), carmelitana col titolo di Madre Francesca dello Spirito Santo, nel 1686 iniziava a Reggio la costruzione del primo monastero femminile dei Carmelitani Scalzi sotto la direzione dei Padri Carmelitani Scalzi dal 1683 a Reggio. Esso sorgeva sull’Angolo di Borgo Emilio. I resti mortali di Madre Francesca sono nel convento delle carmelitane scalze a Montegibbio di Sassuolo. Si dice che si udissero forti colpi all’interno del suo sarcofago quando stavano per avvenire fatti dolorosi alla Casa d’Este. La Beata Scopelli faceva udire tre colpi allo stipite della porta del parente morente quando si salvava. Questo fino alla sesta generazione. Fatti straordinari tramandati nel tempo, che denotano la venerazione di queste grandi donne emiliane.
La caratteristica comune di ogni novità spirituale è che essa è sempre mandata avanti da due persone contemporanee in ambiti diversi, ma complementari, e che non si conoscono direttamente. Già abbiamo visto la complementarietà delle figure della Beata Giovanna Scopelli e della Beata Arcangela Girlani, del Correggio e dell’Ariosto, della Beata Domenica Lazzeri e di Maria De Morl. Le figure sono sempre doppie perchè comprendono l’una l’aspetto della passione, l’altra quello della resurrezione dell’umanità redenta da Cristo.
A Reggio due uomini come il Correggio e l’Ariosto scoprono tutta la ricchezza della femminilità. Non sono state le donne a scoprirla ma due uomini, perchè essa è un valore trinitario, che solo gli uomini sanno vedere e valorizzare. Come sono stati degli uomini a tramandarci la storia delle beate Scopelli, Girlani e e di Santa Caterina Vigri. Era la loro femminilità a mostrarsi nella disponibilità a sacrificarsi per dare la vita agli altri. L’Ariosto ha scoperto l’aspetto della passione della donna, il Correggio quello della resurrezione.